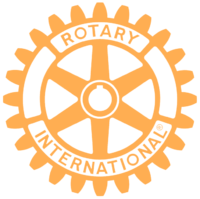Rotary Club Parma
Il Rotary Club Parma è stato il primo dell’Emilia Romagna ad essere costituito e la sua fondazione risale al 1925 sotto la guida del primo presidente Avv. Vincenzo Paltrinieri.
Dopo una breve pausa forzata tra il 1927 e il 1928 in quest’ultimo anno il Rotary riprende le attività, ricordando che le sue manifestazioni non sfiorano mai argomenti di carattere politico, fattore fondamentale in quel tempo. Il presidente che lascia la traccia più profonda in quegli anni è il prof. Francesco Lasagna primario otoiatra dell’Università di Parma, presiederà la delegazione italiana al congresso di Chicago nel 1930. A lui si deve la giornata correggesca avvenuta il 6 maggio 1935, in occasione della mostra per il IV centenario della morte di Correggio. Convergeranno a Parma circa 300 Rotariani tra Italia, Francia e Svizzera. Sarà l’ultimo evento ad ampio respiro perchè la guerra imminente costringerà nel 1938 i Rotary italiani ad autosopprimersi. Infatti l’internazionalità, il pacifismo e l’origine democratica del Rotary non sono graditi al fascismo.
Solo nel 1948, il Rotary Club di Parma riprende a funzionare, sotto la presidenza del prof. Teodosio Marchi, all’appello i soci saranno 48.
Proprio nell’anno della ripresa sarà il socio, notaio dott. Enrico Bandini, a proporre al Club l’idea di promuovere la costruzione di un’autostrada fra Parma e La Spezia. I lavori dureranno dal 1962 al 1975, e dimostrano come la realtà della A 15, importante arteria di collegamento fra Tirreno e pianura padana, con proiezioni verso il centro Europa, si deve ad un’idea sorta e sostenuta concretamente dal Rotary Club di Parma.
Dalla fondazione fino ad oggi le comunicazioni tenute alle conviviali, sono tutte di grande rilievo sociale, economico e culturale.
Sono significative le manifestazioni realizzate in occasione della celebrazione del cinquantenario di fondazione del Rotary Club di Parma, volute ed organizzate il 3 ottobre del 1975 dal presidente dott. Ferruccio Micheli, culminate nella cerimonia ufficiale presso la Biblioteca Palatina.
Per solennizzare l’evento viene pubblicato, in accordo con la Deputazione di Storia Patria, un importante volume con la riproduzione di tutte le piante antiche della città di Parma.
Così come la solenne celebrazione del 60° anno di fondazione il 10 ottobre 1985, sotto la presidenza del dott. Ercole Negri. Per l’occasione viene dato alle stampe un volume storico (non agiografico) sui “Sessant’anni del Rotary Club Parma (1925-1985)” ad opera dei rotariani V. Banzola, G. Erluison, A. Valpondi. Nel 2025 ricorrerà il centenario.
Il Rotary Club di Parma, ha espresso finora due governatori di notevole rilievo: il comm. Pier Celestino Favaro, per l’anno rotariano 1968-1969, ed il prof. arch. Franco Carpanelli, per l’anno rotariano 1987-1988.
Presto si aggiungerà un terzo governatore per l’annata 2021-2022 dott. Stefano Spagna Musso.
La città ha origini antichissime, la colonia romana di Parma venne fondata nel 183 a.C dai triumviri romani M. Emilio Lepido, T. Ebuzio Caro e L. Quinto Crispino, nella zona che aveva come centro l’attuale piazza Garibaldi. Ad oggi tale piazza è ancora il fulcro della vita cittadina delimitata dal Palazzo del Comune e dal Palazzo del Governatore oggi utilizzato per eventi e mostre.
Anticamente il nucleo della città era delineato da via Melloni a nord, via Longhi e via San Silvestro a est, borgo Riccio e via al Ponte Caprazucca a sud, Via del Conservatorio e via Carducci a ovest corrispondenti all’antica sponda del Torrente Parma. Tuttora il torrente svolge una funzione fondamentale dal punto di vista urbanistico suddividendo la città in due parti collegate da numerosi ponti.
Parma ha quindi origini romane e già durante questo periodo godette di un certo benessere economico, legato alla fertilità della terra. Quindi è sempre stata legata alla ricchezza del suo territorio e dei suoi prodotti proprio come avviene oggi.
Uno dei monumenti più antichi della città è il cosiddetto “Ponte romano” in pietra, che vide la luce sotto Teodorico, del quale sono ancora visibili i resti nell’attuale Piazza Ghiaia, chiamata così perché era l’antico letto del torrente e poi trasformata in zona adibita a mercato alimentare.
Nel 570 Parma venne invasa dai Longobardi. Poi arrivarono i Franchi e divenne un contado dal IX sec fino al primi del XII, in questo frangente venne istituito un potere vescovile e durante questo governo l’istruzione pubblica ebbe un ruolo pregnante. Il vescovo Wibodo istituì il Capitolo della Cattedrale fondando una scuola per futuri sacerdoti che nell’XI secolo venne aperta a tutti nella quale vanno ricercate le origini dell’Università di Parma, tra le più antiche d’Italia. Ed ancora oggi viene considerata un’eccellenza della nostra città. Attualmente la nostra Università cittadina ha varie sedi, tra cui anche un Campus Univesritario Polo delle facoltà scientifiche, ma la sede centrale in via Università è tutt’ora operativa.
Nel 1149 scompare il potere temporale della Chiesa a Parma, intanto scendeva in Italia Federico I (detto Barbarossa) Parma si schiera contro quest’ultimo così come altre città italiane prima di lei, ed alcuni parmigiani erano presenti alla celeberrima battaglia di Legnano (1176) che segnò la sua definitiva sconfitta. Sorte simile capitò al nipote, Federico II di Svevia, al quale venne inflitta una sonora sconfitta proprio a Parma nel 1248.
Parma nel frattempo si allea con le città vicine e ne combatte altre (soprattutto Piacenza) a seconda delle necessità del momento. È questo anche il periodo in cui si afferma il Romanico come stile ancora visibile nel Duomo, Battistero e Vescovado. I tre monumenti sono tuttora visitabili nella nostra Piazza Duomo, l’antico fulcro religioso che i tre edifici abbracciano. In essi sono racchiusi ben tre secoli di storia e si può leggere il passaggio tra il romanico più grezzo a quello più elegante e leggero che profuma di gotico che ha la sua maggior espressione proprio nel Battistero di Antelami. Altri monumenti del periodo romanico a Parma sono la chiesa di Santa Croce, pochi invece sono i monumenti gotici come San Francesco del Prato (ora riportato a nuova luce), la chiesa del Carmine, mentre appena fuori città abbiamo l’Abbazia di Valserena che ci rimanda allo stile Cistercense.
Tra il 1346 e il 1447 Parma cadde in mano ai Visconti, dopo due anni di indipendenza nel 1449 la città fu costretta a giurare fedeltà a Francesco Sforza.
Successivamente a Sforza molte famiglie rivaleggiarono causando devastazione e morti, si aggiunse inoltre una violenta pestilenza e la città passò da un padrone all’altro (Francia, Papato) e queste protezioni divennero per lei indispensabili. E fu intorno agli ultimi decenni del ‘400 che a Parma fiorì il Rinascimento, a questo periodo si deve la costruzione della benedettina chiesa di San Giovanni collocata appena dietro il Duomo, lì si possono ammirare i capolavori del Correggio così come nel convento delle benedettine di San Paolo, dove ha operato anche l’Araldi. Descrivendo Parma non si può tralasciare la chiesa della Steccata , una delle prima costruzioni a croce greca della nostra città.
Nel 1545 Paolo III creò il Ducato di Parma e Piacenza e ne investiva il figlio Pier Luigi, in 185 anni di regno si succedettero ben 8 duchi. Importante ricordare il governo del duca Ranuccio I Farnese, dal carattere cupo e diffidente si distinse oltre che per i traguardi politici anche per quelli culturali, concedendo privilegi all’università, costituì il Collegio dei Nobili affidato ai Gesuiti.
A lui si deve la costruzione del vasto complesso della Pilotta con il famoso Teatro Farnese ancora oggi uno dei luoghi culturali più importanti della nostra città.
I Farnese furono importantissimi per creare un nuovo assetto del disegno cittadino, a loro si deve la costruzione nell’Oltretorrente delle chiese dell’Annunciata e del Quartiere.
Ma sarà nel 1748 con la pace di Aquisgrana sotto Filippo di Borbone e la moglie Elisabetta che Parma inizia a prendere le forme di “petite capitale” ad imitazione di Parigi, e fecero del magnifico palazzo di Colorno la loro Versailles. il ministro Guglielmo Du Tillot fece diverse riforme in campo culturale circondandosi di intellettuali e studiosi. Tra questi l’architetto Petitot al quale si deve l’organizzazione urbanistica della città, con il famoso “stradone” che percorriamo ancora oggi.
Altro monumento di spicco della nostra città è senz’altro il Teatro Regio in Via Garibaldi, che si deve a Maria Luigia d’Austria, il regno di quest’ultima ha coinciso con la piena fioritura dello stile neoclassico.
Molte cose sono successe nel frattempo ma è nel dopoguerra che la città ha avuto una forte espansione demografica e urbanistica e un notevole sviluppo economico e industriale dovuto soprattutto al comparto agroalimentare i cui eccellenti prodotti sono diffusi ormai in tutto il mondo. Nel 2003 Parma è diventata anche sede dell’EFSA la agenzia europea per la sicurezza dei prodotti alimentari.
Quindi si può dedurre che fin dall’antichità Parma ha giocato un ruolo importante per il suo territorio ed ha sempre cercato di essere personalità trainante per altre città.
In questi anni era già da tempo che veniva chiamata “Capitale della Food Valley” ma ha meritato anche il riconoscimento di “Città creativa per la gastronomia” conferitole dall’UNESCO.
Un traguardo ampiamente meritato grazie alle sue eccellenze gastronomiche famose in tutto il mondo.
Tra i prodotti che tutto il mondo ci invidia sicuramente il Parmigiano Reggiano, Re dei Formaggi, e i salumi e insaccati realizzati con le stesse tecniche artigianali di una volta. Il Crudo di Parma che deve la sua qualità alla speciale stagionatura sulle ventose colline di Langhirano e il Culatello di Zibello che si arricchisce degli umidi profumi delle terre golenali del Po. Il salame di Felino e la Spalla Cotta di San Secondo, spesso accompagnati alla torta fritta, una speciale sfoglia di acqua e farina a forma rettangolare, soffice e croccante al tempo stesso, e innaffiati da Lambrusco. Fra i piatti più tipici e golosi gli anolini in brodo di cappone e i tortelli d’erbetta. Fra i secondi è ancora in voga la trippa alla parmigiana mentre dalle zone di montagne arrivano le delizie del sottobosco, fra cui i Funghi di Borgotaro Dop, ottimi con il rosso Fortana del Taro Igt, un antico vitigno autoctono della Bassa Parmense.
Tutte queste caratteristiche unite insieme ad una rete di consorzi ed imprenditori capaci di fare squadra hanno fatto sì che Parma ricevesse l’ambito riconoscimento.
https://www.parmacityofgastronomy.it/parma-unesco-creative-city-of-gastronomy/