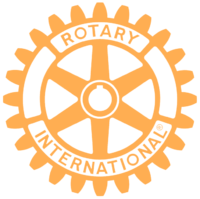LA FONTANA DELLA PIGNA
“Bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma” scrisse il poeta romantico inglese P.B. Shelley.
Per i Romani l‘acqua era un dono degli dei, l‘Urbe fu subito disseminata di luoghi d‘acqua e ogni fonte aveva un suo nume tutelare, le ninfe.
Le fontane, di cui Roma è ricchissima, sono un patrimonio culturale inestimabile, sono opere mirabili di ingegneria idraulica di 2300 anni fa, testimonianza di come i Romani con l‘acqua hanno sempre avuto un legame fortissimo.
Questi giochi d‘acqua hanno un loro immenso valore artistico. Monumentali, bizzarre, allegoriche, barocche, arredano tutt‘ora le piazze più famose o si svelano in angoli nascosti, piccoli e grandi capolavori firmati dai più celebri maestri dell‘arte, a conferma che la Città Eterna è la capitale indiscussa dei monumenti d‘acqua.
“Roma regina Aquarum“, perché dove c‘è l‘acqua c‘è civiltà, infatti le fontane nelle piazze sono l‘espressione di un immenso patrimonio culturale e sociale e rappresentano validi strumenti di propaganda del potere politico ed ecclesiastico.
Le fontane romane sono oltre duemila, senza contare le fontanelle di ghisa, i celebri “nasoni“, che danno da bere a turisti e cittadini, Dalle più celebri fontane di Piazza Navona, Piazza Fontana di Trevi, Piazza Barberini o Piazza di Spagna, fino a quelle meno conosciute ma altrettanto curiose dei rioni.
Come la fontana della Pigna, che si trova in Piazzetta San Marco, davanti alla Chiesa di San Marco, in un angolo un po‘ defilato rispetto alla caotica Piazza Venezia. Questa graziosa fontana in travertino fu edificata in ricordo di una grande pigna bronzea che fu ritrovata in epoca medievale in questa parte della città, tra le rovine delle Terme di Agrippa o all‘interno dell‘Iseo Campense, il grande Tempio dedicato a Iside in Campo Marzio, dove doveva far parte di una fontana che gettava acqua dalle punte. Questo manufatto del II sec. D.C. portava la firma di un certo Publio Cincio Savio. Poi fu trasferita in Vaticano e fu usata per decorare il centro del quadriportico dell‘antica basilica di San Pietro in Vaticano. Nel 1608 venne infine collocata al centro dell‘esedra del cortile del Bramante, oggi chiamato, appunto, Cortile della Pigna.
La storia di questa particolare fontana inizia però in tempi più recenti, negli anni Venti del Novecento. Quando nel 1926 il Comune di Roma bandì un concorso per sostituire i “nasoni” in ghisa, ritenuti antiestetici e inadatti al centro storico della città, l‘incarico di progettare un gruppo di fontanelle artistiche destinate ad abbellire i rioni di Roma e a sottolinearne al contempo l‘identità storica, fu affidato all‘architetto e scultore Pietro Lombardi. Ne vennero fuori nove piccoli capolavori ispirati agli antichi stendardi, agli emblemi, alla simbologia, agli elementi caratterizzanti dei singoli rioni: la Fontana dei Libri nel Rione Sant‘Eustachio, la Fontana delle Anfore nel Rione Testaccio, la Fontana degli Artisti nel Rione Campo Marzio, la Fontana delle Tiare e la Fontana delle palle di Cannone a Borgo, la Fontana dei Monti nel Rione Monti, la Fontana della Botte a Trastevere, la Fontana del Timone nel Rione Ripa e appunto la Fontana della Pigna. Tutte pregevoli esempi di arredo urbano,
Semplice ed elegante nonostante le dimensioni modeste, la fontana della Pigna è alimentata dall‘Acquedotto dell‘Acqua Marcia ed è costituita da un piccolo bacino dal cui centro si innalza uno stelo. Due corolle di tulipani stilizzati sostengono la pigna simbolo del rione. L‘acqua sgorga da bocchette laterali e dalla sommità della pigna, raccogliendosi a più livelli fino a raggiungere due
vaschette a terra, protette da quattro colonnine marmoree. L‘acqua è come sempre potabile e a disposizione di turisti e cittadini.
La pigna è il filo rosso che collega altri luoghi di questo storico rione, come Piazza della Pigna, Via della Pigna e la chiesa di San Giovanni della Pigna, situate quasi al centro del trapezio che costituisce il territorio del rione omonimo. Per spiegare le origini della toponomastica di questa silenziosa piazzetta situata alle spalle del Pantheon, una curiosa leggenda racconta che anticamente l‘oculus della cupola del Pantheon era sigillato da una grande pigna d‘oro, che i diavoli, che vivevano all‘interno del Tempio di tutti gli Dei, avevano trasportato a Roma. Papa Bonifacio IV (608–615) nel 609 trasformò il monumento pagano in chiesa cristiana con il nome di Sancta Maria ad Martyres e con una solenne processione di clero e di popolo entrò sulle note del Gloria, con 27carri pieni di ossa di martiri provenienti dalle catacombe. Terrorizzati, gli spiriti maligni fuggirono dall‘oculus, prendendo a cornate la grande pigna, che rotolò rovinosamente nella piazzetta retrostante, dove poi fu rinvenuta e che da quel momento prese il nome di Piazza della
Pigna. Ma alla base di ogni leggenda vi è sempre un profondo messaggio e un poliedrico significato simbolico. La pigna, con i suoi semi, racchiude un significato di sopravvivenza della virilità e per estensione un antidoto alla mortalità umana, indica la carica vitale, la fertilità, la fecondità e la vita. Questa storia, fatta di arte, leggende, curiosità, fatti realmente accaduti, rappresenta la doppia anima di Roma: sacra e profana, oscura e luminosa, magica e realista, caotica e creativa. Rappresenta il suo essere eterno, perché senza tempo, dove le vestigia di 3000 anni di storia si sono sedimentate e convivono, rappresentando la bellezza e il peso che questa città sopporta.
Ma Roma questa s–conosciuta, anche negli angoli più inaspettati dispensa meraviglie, sorprese, storie insolite, miti e riti, che non finiscono mai di stupire. E‘ più che mai vera la definizione che dell‘Urbe fece il grande Ennio Flaiano che non si può non condividere:
“Roma è inconoscibile, si rivela col tempo e non del tutto. Ha un‘estrema riserva di mistero e ancora qualche oasi.”